![]()
Lo Stato Pontificio venne annesso al Regno d’Italia, dopo il plebiscito dell’ottobre
1860.
In
seguito a ciò, Rieti entrò a far parte della provincia dell’Umbria [1]
(doc.
1a, 1b,
1c, 1d),
che venne divisa in sei circondari: Perugia, Spoleto, Rieti, Foligno, Terni e
Orvieto. Ad essa fu unita la Sabina, con un decreto che istituiva un solo
consiglio provinciale.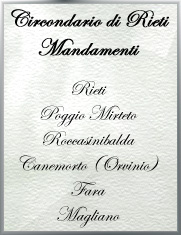
Qualche mese dopo l’annessione, l’amministrazione cittadina, tra gli altri problemi organizzativi, si trovò ad affrontare quello della riforma delle scuole (doc. 2, 3).
All’istruzione elementare di tutta la provincia, il commissario generale Pepoli aveva destinato i beni della soppressa Compagnia di Gesù [2] e £10.000 per l’istituzione di un convitto nazionale (doc. 4, 5a, 5b, 5c).
Sotto l’impulso delle norme commissariali e governative e le ripetute sollecitazioni del provveditore L. Palmucci, che chiedeva come sarebbero state spese le 16436 lire assegnate [3], la giunta reatina stilò un progetto per la gestione pubblica dell’istruzione.
Il progetto fu approvato e anche lodato dal provveditore, il quale riteneva che sarebbe stato “molto di conforto al governo ed avrebbe recato copiosi frutti e larghi compensi”, perché prevedeva una riforma ed un ampliamento degli organismi scolastici, che scaturivano da un conoscenza non superficiale di alcuni aspetti della società reatina. La città “purtroppo” aveva bisogno di una maggior istruzione, possibilmente “opportuna” alle condizioni del paese appena unificato (doc. 6).
Le scuole elementari previste [4] erano composte di quattro classi (1°, 2°, 3° e 4°), ognuna con un maestro; la scuola ginnasiale con cinque insegnanti rispettivamente per le cinque classi, due incaricati, un direttore spirituale ed un bidello [5]; le scuole tecniche avrebbero dovuto avere tre professori e quattro incaricati; infine era prevista la costituzione di un liceo di terza categoria (doc. 7) dove sarebbe stato espletato un corso di filosofia razionale, nel quale far confluire le classi superiori dell’area ginnasiale e anche di quella tecnica.
La novità del progetto però consisteva nella creazione di una Sezione agronomica, con quattro professori, tre incaricati, un assistente al gabinetto di chimica ed un inserviente (doc. 8, 9, 10, 11, 12, 13).
Nel clima di fermento e nello sforzo innovativo che trapelava dai primi atti consiliari, oltre all’enfasi e alla retorica traspariva anche qualche sprazzo di concreta analisi della realtà cittadina. I membri della giunta, considerando le “condizioni agricole del (…) paese”, ritenevano molto importante avviare una Sezione agronomica, anche se soltanto di livello inferiore.
Essi consideravano le scuole tecniche molto speciali, perché avrebbero dato dei risultati immediati, rispetto alle esigenze economiche e sociali che si trovavano a fronteggiare; infatti ritenevano che il loro risultato si sarebbe manifestato più direttamente nella “classe industra e artistica del popolo”.
Le
scuole elementari furono attivate immediatamente; la legge dava ai municipi una
responsabilità diretta, ma non per questo priva di difficoltà, come si dirà
in seguito. 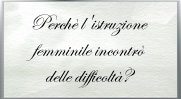
Per quanto riguarda l’istruzione femminile [6], nel bilancio del 1861 vennero stanziate 200 lire, mentre fino ad allora era stato erogato un sussidio di 50 lire. In seguito sorsero alcune difficoltà, che dovrebbero essere maggiormente approfondite, per utilizzare la somma prevista nel bilancio.
Tale somma avrebbe consentito, almeno in parte, un incremento dell’istruzione femminile rispetto agli anni precedenti (doc. 14, 15, 16a, 16b, 16c, 16d, 16e, 16f, 16g, 16h, 16i, 17).
Il consigliere Filippo Antognoli propose una soluzione che era estremamente ambigua: fino a quando le scuole femminili sarebbero rimaste presso le Maestre Pie, senza modifiche strutturali, il sussidio di £. 50, versato ad esse negli ultimi anni, sarebbe rimasto inalterato. Ma se nel progetto non si prevedevano alternative qualificate, quando e come l’istruzione destinata alle fanciulle poteva subire modifiche?
Nell’aprile dell’anno successivo, il presidente della Congregazione di Carità costatando che il convitto di San Paolo era frequentato da “un immenso numero di giovinette” e ricordando l’obbligo del comune di provvedere ai locali delle scuole e di favorire in ogni modo l’incremento dell’istruzione elementare, chiese all’amministrazione di sostenere la spesa di £. 2752 per l’ampliamento dei locali. La maggioranza approvò la costruzione di un nuovo edificio sopra quello già esistente, a condizione che il nuovo fabbricato restasse di proprietà del comune, o questo ne venisse indennizzato, mentre fu respinta la proposta di adeguare la facciata della chiesa, con una spesa che sarebbe ammontata a 30 lire.
Nel giro di poco tempo si affievolì notevolmente il clima di fermento riformatore. Non furono realizzati né il Liceo, che invece fu eretto a Spoleto, dove in seguito si recarono gli studenti reatini per completare il corso superiore degli studi, né si riuscì ad impiantare la Sezione agronomica, tanto agognata.
Il fallimento di questo ultimo progetto rappresentava forse il fatto più grave e significativo.
Non si trattava solo di un’opportunità
mancata; se non era in discussione la disponibilità finanziaria, allora le
cause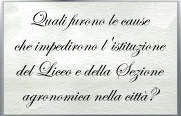 dovevano essere legate a problemi strutturali. “La
molteplicità delle cattedre vacanti”, il “novello
metodo” dei nuovi insegnamenti rendevano difficoltoso l’impianto della
pubblica istruzione specialmente tecnica e delle materie scientifiche “inusitate
ed ignorate nei precedenti sistemi delle nuove province”. Queste
difficoltà poi crescevano nel caso di scuole tecniche superiori. Nonostante gli
sforzi fatti dall’amministrazione comunale per aprire un istituto agrario
anche di grado inferiore, questa non
riuscì nell’intento.
dovevano essere legate a problemi strutturali. “La
molteplicità delle cattedre vacanti”, il “novello
metodo” dei nuovi insegnamenti rendevano difficoltoso l’impianto della
pubblica istruzione specialmente tecnica e delle materie scientifiche “inusitate
ed ignorate nei precedenti sistemi delle nuove province”. Queste
difficoltà poi crescevano nel caso di scuole tecniche superiori. Nonostante gli
sforzi fatti dall’amministrazione comunale per aprire un istituto agrario
anche di grado inferiore, questa non
riuscì nell’intento.
La lungimiranza posta nel prevedere l’efficacia di una scuola che fosse da stimolo per il settore agricolo, predominante nell’economia cittadina, non fu affiancata dalla capacità di superare le innumerevoli difficoltà.
Difficoltà di trovare insegnanti preparati dal punto di vista
tecnico scientifico, preoccupazione di avere un numero insufficiente di “discepoli”,
visto come una “conseguenza dello stato
di abbandono nel quale si è 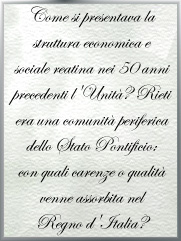 lasciata per lo innanzi l’arte agricola, (…) del
poco conto nel quale si è tenuto nei passati tempi l’agronomo, del niuno
incitamento dato nel perfezionare e coltivare la scienza agronomica”. Il
sussidio di 10.000 lire, accordato con il decreto del 13 dicembre 1860 con lo
scopo di istituire un convitto nazionale, fu destinato alla realizzazione di
altre scelte educative, sempre in linea con le esigenze governative.
lasciata per lo innanzi l’arte agricola, (…) del
poco conto nel quale si è tenuto nei passati tempi l’agronomo, del niuno
incitamento dato nel perfezionare e coltivare la scienza agronomica”. Il
sussidio di 10.000 lire, accordato con il decreto del 13 dicembre 1860 con lo
scopo di istituire un convitto nazionale, fu destinato alla realizzazione di
altre scelte educative, sempre in linea con le esigenze governative.
La metà della somma fu indirizzata per ampliare e perfezionare l’asilo d’infanzia esistente presso l’Orfanotrofio di San Davide (doc. 18, 19a, 19b, 20), per aprire delle scuole notturne maschili e delle scuole rurali.
L’opportunità
di scuole notturne urbane e rurali era dovuta al fatto che si sarebbe portato l’insegnamento
a “tanta gioventù cui
le necessità domestiche, le arti lavorative, la campagna tiene lungi dalle
scuole diurne”; queste avrebbero permesso di aprire il tesoro dell’istruzione “alla classe laboriosa
ed artistica della città e territorio”, perché tutti i membri del
consiglio dovevano aver ben fisso in mente che ”allorquando
non esisteranno più analfabeti, dall’artista al dotto, dal mendico al ricco,
tutti sapian leggere e scrivere, allora sarà l’epoca del termine dei
pregiudizi, sarà l’epoca della vera libertà della Nazione, sarà l’epoca
della morte della schiavitù fisica e morale”.
La restante quantità di denaro fu
destinata al mantenimento agli studi superiori di due alunni del ginnasio e due
delle scuole tecniche di disagiata condizione economica (doc. 21a, 21b,
21c, 21d,
21e, 21f,
21g, 21h).
Secondo l’opinione di alcuni consiglieri dovevano essere giovani di eletto
ingegno, di buona morale oppure di povera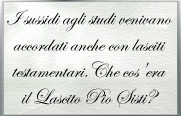 condizione, che erano restii a
proseguire gli studi; infatti essi avevano certezza che molti “belli
e svegliati ingegni ora intorpidiscono nelle arti manuali, nella miseria e
nell’inerzia” [7].
condizione, che erano restii a
proseguire gli studi; infatti essi avevano certezza che molti “belli
e svegliati ingegni ora intorpidiscono nelle arti manuali, nella miseria e
nell’inerzia” [7].
Torniamo brevemente alla gestione dell’asilo d’infanzia.
La redazione di un regolamento per l’Asilo d’infanzia era stato commissionato dal consiglio comunale il 17 ottobre del 1861 [8] (doc. 22a, 22b, 22c, 22d).
Ad esso potevano accedere bambini dai tre anni e mezzo fino ai sette, era destinato a fanciulli e fanciulle appartenenti a famiglie di operai, che per esercitare il lavoro da cui traevano il loro sostentamento li avrebbero abbandonati per molte ore al giorno, anche se potevano essere ammessi figli di famiglie benestanti dietro il pagamento di un contributo di tre lire mensili.
I bambini venivano separati dalle bambine e confluivano in due classi a seconda dell’età e “dell’intelligenza”; durante i pasti e la ricreazione le classi venivano riunite, ma i bambini e le bambine continuavano a rimanere divisi.
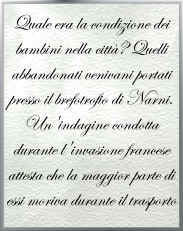 La direttrice dell’istituto era per diritto la Superiora dell’Orfanotrofio,
le maestre erano due e venivano scelte tra le orfane del medesimo istituto.
La direttrice dell’istituto era per diritto la Superiora dell’Orfanotrofio,
le maestre erano due e venivano scelte tra le orfane del medesimo istituto.
Esse dovevano impartire i primi rudimenti della istruzione, lettura, esercizi di scrittura, poi del “calcolo parlato” e della educazione religiosa e morale. Per le bambine erano previsti anche lavori di ago e cucito. Gli ordini, le cadenze degli orari, venivano impartiti con il battere delle mani, il suono del campanello, il colpo di una bacchetta sul tavolino. Le punizioni corporali erano assolutamente proibite, ma in taluni casi i bambini potevano essere rimproverati, quindi separati dai compagni, posti nel mezzo o nell’angolo della sala, fatti camminare fuori o in fondo alla fila, oppure mangiare e giocare in disparte.
Per premio potevano essere lodati in pubblico o per iscritto sul registro, o ricevere piccoli regali di cose utili alle famiglie.
Un commissione comunale controllava l’andamento dell’istituto; i pasti consistevano in una minestra giornaliera, tre volte il pane e la carne una volta alla settimana, la visita del medico avveniva una volta alla settimana [9].
Tra
le difficoltà più volte ricordate dai consiglieri si ha principalmente quella
del reperimento degli insegnanti. La politica di incremento dell’istruzione
per colmare l’esteso analfabetismo, rese visibile la carenza di insegnanti (doc.
23a, 23b,
24)
e a volte l’inadeguatezza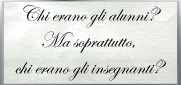 della loro preparazione.
della loro preparazione.
Per fare un esempio ci limitiamo a riportare i dati dell’elezione dei maestri delle scuole elementari.
La commissione composta da Michele Micheli, Basilio Sisti, Francesco Palmegiani e Paolo Simeoni, dopo aver esaminato le istanze e i documenti degli aspiranti maestri elementari, considerò idonei, in base ai titoli riportati, Giovanni Marcucci (1° classe) e Don Paolo Paparelli (2° classe), mentre decise di sottoporre a concorso gli altri.
La medesima commissione sottopose i due concorrenti presentatisi, Giuseppe Giorgetti e Giuseppe Carloni a “esperimento”, promuovendo solo quest’ultimo per la 4° classe, ma restava ancora vacante il posto per la classe 3°.
Dopo un nuovo concorso [10], applicando la legge che dava ai municipi l’opportunità di eleggere i maestri, il consiglio decise di effettuare un ballottaggio dal quale risultò designato Mariantoni Teofilo, anche se non aveva ottenuto il punteggio più alto.
Durante il consiglio del 30 giugno 1862, il cav. Ippolito Vicentini lesse il verbale di sospensione di alcuni incaricati: padre Ceslao Carones direttore spirituale provvisorio del ginnasio, Don Paolo Paparelli maestro della 2° classe maschile, Don Luigi Carloni prefetto delle scuole elementari (doc. 25, 26). Tale verbale era stato precedentemente approvato dall’ispettore provinciale e dal provveditore, i quali ravvisarono “la necessità di surrogarli con personale d’istruzione e di educazione con idee ed affetti più conformi ai bisogni odierni del paese”, in quanto non erano intervenuti alla festa nazionale del 2 giugno.
Per sostituire il prefetto delle scuole elementari la giunta effettuò un nuovo concorso; era stata consegnata una sola domanda, dal sacerdote Cristoforo Matricard; allo scadere del termine fu presentata l’istanza da don Giovanni Battista Angelucci (doc. 27a, 27b, 27c). La giunta espresse il parere favorevole per quest’ultimo.
Per quanto riguardava l’ufficio di direttore spirituale, nessun aspirante presentò l’istanza per ottenere l’incarico.
Soltanto don Filippo Agamennone consegnò, dopo il termine utile, la sua richiesta, affermando però che la sua sospensione a divinis gli avrebbe impedito di espletare l’obbligo della messa. Egli prima di accettare l’incarico, pose la condizione di restringere tale obbligo ai soli giorni festivi. In questo modo avrebbe limitato le spese che il conferimento di dire messa ad un altro sacerdote avrebbe comportato.
La giunta, vista la mancanza di concorrenti, gli concesse provvisoriamente l’incarico, ma una volta cessata la sospensione, avrebbe celebrato egli stesso le messe previste nell’accordo.
Anche l’anno successivo si dovettero adottare provvedimenti sospensivi.
Il prefetto delle scuole, don Angelucci e il maestro della 4° elementare, Giovanni Benedetto Monti, impegnato anche nelle scuole tecniche, si erano rifiutati di partecipare alla festa nazionale dello statuto, un fatto ritenuto molto grave dal consiglio, perché contrario ai doveri del maestro, il quale invece avrebbe dovuto costituire un esempio per l’educazione patriottica degli alunni.
Queste
brevi note sono riferite solo ad alcuni anni della storia “unitaria” cittadina; nonostante ciò pongono molteplici
interrogativi che necessitano di chiarimenti ed approfondimenti, ma soprattutto
rappresentano un invito a seguire le possibili evoluzioni dei fatti connessi all’istruzione
pubblica nel reatino (doc.
28a, 28b,
28c, 28d,
28e, 28f,
28g, 28i,
28l, 28m,
28n, 28o,
28p, 28q,
28r, 28s).

[1]
Decreto del regio commissario Pepoli, 15 dicembre 1861, n°197
[2]
Regio decreto 29 novembre 1860.
[3]
R.D. 10/2/1861
[4]
A.C. Rieti, Deliberazioni del consiglio comunale, 1861, n° 1 1e n° 2,
1862-1863.
[5]
Le scuole elementari e le
ginnasiali erano già presenti, anche se diverse nel sistema e nel
personale.
[6]
Alcune erano state istituite presso i convitti di San Paolo, del Bambin Gesù
e successiva-
mente
anche presso S. Caterina.
[7]
Il regolamento per l’assegnamento dei sussidi a studenti non abbienti fu
redatto nel 1863. Cfr. nota 4
[8]
Cfr. nota 4.
[9]
Cfr. nota 4.
[10]
Ceccotti Tommaso (16 e ¾), Marcantoni Teofilo (15 e ¼), Fioritoni Angelo
(13),